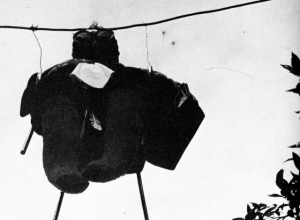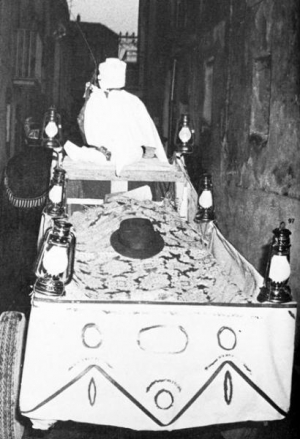Mimmo Ferraro
000 Pagani 1987
Rilevazioni condotte da Paolo Apolito a Pagani (Sa) nel 1987 in occasione della festa della Madonna delle Galline che si tiene la domenica in albis. La raccolta documenta canti sul tamburo con voci maschili e femminili e testimonianze di devoti che commentano l'esperienza di una presunta apparizione mariana in quell'occasione e in altri momenti di intenso misticismo vissuti personalmente o attraverso altrui racconti.
000 Olevano sul Tusciano
Il piffero che suona in onore di San Michele Arcangelo a Olevano si iscrive in una tradizione con radici lontane nel tempo; come testimoniano anche i flauti in osso ritrovati nella grotta dell'Angelo, uno dei depositi più cospicui del periodo medievale nell'Europa meridionale, l'utilizzo del piffero ha notevole rilevanza nell'area, una tradizione che tuttavia rischia di perdersi. La lunga performance che compone questa raccolta, restituisce una preziosa testimonianza della tecnica esecutiva e dell'estetica del repertorio olevanese sul piffero, repertorio eseguito durante la processione per San Michele guidata dai suonatori di piffero e tamburo e dagli sbandieratori.
000 Nola 1980
La domenica successiva al 22 giugno si svolge a Nola (Sa) la processione danzante in onore di San Paolino con macchine votive a spalla lungo il tradizionale tracciato individuato nel nucleo più antico della cittadina. Al ritmo della musica (brani originali e reinterpretazioni attinte dalla tradizione musicale napoletana, italiana e internazionale) si muovono gli otto obelischi di legno, omonimi delle antiche corporazioni delle arti e mestieri, denominati Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto, più una struttura a forma di barca, simbolo del ritorno in patria del santo. Tali costruzioni lignee, denominate poi Gigli, hanno assunto a partire dall'800 l'attuale altezza di 25 metri con base cubica di circa tre metri per lato, per un peso di oltre venticinque quintali. L'elemento portante è la borda, asse centrale; le varre e varrette sono assi di legno atte a manovrarli. Vengono addobbati dagli artigiani locali di decorazioni in cartapesta, stucchi o altri materiali secondo temi religiosi, storici o d'attualità. I Gigli e la barca vengono sollevati a spalla dalla rispettiva paranza, gruppo di circa 120 uomini; su ciascun giglio trova posto anche la banda musicale. Gli addetti al trasporto dei Gigliassumono il nome di cullatori, in dialetto e cullature, per l'andamento oscillante simile all'atto del cullare. Apolito registra, nel 1980, l'evento che precede la festa: circa un mese prima le bande dei diversi rioni girano per le strade, proponendo il loro repertorio e l'ultima canzone del giglio, accompagnati da un furgone attrezzato per l'amplificazione. La kermesse di folla itinerante e caotica che si crea è del tutto simile a quello che avverrà il giorno della festa, quando la banda si posizionerà sulla struttura stessa del Giglio. Tra i documenti l'intera sequenza (in ordine di sfilata) di canzoni dei Gigli relative al 1979 incise su disco.
000 Montesano sulla Marcellana 1980
Tra ricordi personali, leggende e l'esecuzione di canti tradizionali, un uomo di Montesano sulla Marcellana, del quale non sono documentate le generalità, incontrato dal ricercatore il 19 ottobre del 1980, riferisce di riti legati a santi patroni, culti mariani e usanze praticate in particolari periodi dell’anno, dai cibi rituali alle feste tradizionali.
In particolare l’interlocutore ricostruisce le forme della festa in onore di Sant’Antonio da Padova, condividendo storie, leggende e canti tradizionali. A Montesano sulla Marcellana questa è, infatti, una ricorrenza religiosa molto sentita e non a caso è stata proprio la chiesa di S. Francesco ai Cappuccini che ha accolto, per la prima volta nel Vallo di Diano, le Reliquie del Santo nel 2010. L’ultimo sabato di giugno, ancora oggi, parte la tradizionale processione dal convento dei Frati Cappuccini che vede le statue di Sant’Antonio e San Francesco, portate a spalla da un gruppo di devoti attraverso il centro storico della città fino a giungere alla chiesa di Sant’Anna, tra i canti devozionali e le marce suonate dalla banda del paese. L’intervistato, inoltre, esegue alcuni canti in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, figura verso la quale nutre una profonda devozione, e racconta la leggenda di fondazione del culto attraverso memorie e aneddoti. I festeggiamenti in onore della "regina e patrona della Lucania" richiamano migliaia di pellegrini che la prima domenica di settembre, ogni anno, da tutte le regioni del Mezzogiorno, raggiungono il paese della Val d’Agri per partecipare alla processione durante la quale la sacra effige viene trasferita dal santuario del Sacro Monte alla Basilica Pontificia dove resta sino al mese di maggio. In fila migliaia di pellegrini pregano e cantano invocando la protezione della Madonna nera di Viggiano, accompagnandola a piedi per i dodici chilometri che separano il monte dal paese: si cammina scalzi, in alcuni inginocchio, seguendo il lungo percorso scandito dai poggi (antichi altari di pietra sui quali la statua viene poggiata per permettere ai portatori di riposarsi), dietro agli stendardi portati dai giovani e ai cinti portati dalle ragazze, accompagnate da zampogne e organetti.
000 Giovi Casale 1978
Breve raccolta di canti, filastrocche e scioglilingua, narrati da Paolo Genovese il 24 aprile del 1978 a Giovi Casale, piccolo nucleo abitativo nel salernitano. Tra canti ironici e d’amore, racconti e filastrocche si disegnano i tratti di un ricco patrimonio orale, tramandato attraverso le generazioni, e oggi a rischio di estinzione.
000 Giovi 1978
Una sacra rappresentazione, musiche bandistiche, canti tradizionali, eseguiti con l’accompagnamento di tammorre e organetti, e il paesaggio sonoro della festa della Madonna dei Campi a Giovi, frazione salernitana, il lunedì di Pentecoste, a propiziare l’inizio della stagione dei lavori agricoli. A maggio, infatti, si canta l’inno e si recita la preghiera d’intercessione per la protezione di vigneti, famiglie e animali: consuetudine antica è la benedizione della terra, intrecciata alla tradizione popolare di racconti d’eventi speciali attribuiti alla Vergine, che sarebbe apparsa ad una pastorella. Da allora, non sono mancati prodigi straordinari: in tempi di difficoltà si suonavano le campane contro piogge violente o infestazioni di cavallette. Nei secoli il culto mariano ha valicato i confini geografici di Giovi, se si tiene conto che per devozione, fino a pochi anni fa, tanti erano i pellegrini provenienti dalla Piana del Sele, dalla Valle dell’Irno e dalla città di Salerno.
Gli abitanti di Giovi, ancora oggi, destinano il giorno della festa al totale riposo, riversandosi nella chiesa per assistere alla messa, portando ciascuno il suo cero e l’offerta in denaro, ed infine partecipano alla processione del mezzogiorno.