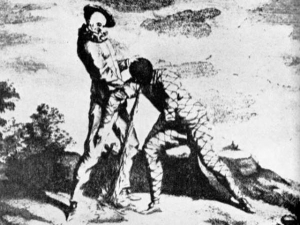Mimmo Ferraro
01 Disegni di G. J. Xavery
02 Napoli, fuoco di S. Antonio Abate
01 Liveri, travestimento da donna
01 Piazza di Pandola
00 Rosa Di Lillo, Teggiano 1981-82 (05-06)
La raccolta, nell'ambito della più ampia indagine sulla cultura orale di Teggiano, si distingue per un'elevata concentrazione di cunti e favole, alcuni ripetuti e interpretati a più voci o da diversi informatori. I racconti includono quasi sempre delle parti in rima recitate a memoria che indicano un elemento centrale delle culture orali, ovverosia, il continuo replicare e sedimentarsi di formule e storie ripetute "a voce". Oltre agli splendidi esempi di fiabe e storie narrate dagli anziani informatori, si trovano alcune ninne nanne, testi di ambito religioso e di argomento amoroso, ai quali si aggiunge una rilevante e lunga performance musicale eseguita da alcuni cantori locali accompagnati da un organetto.
00 Rosa Di Lillo, Teggiano 1981-82 (03-04)
Questa parte delle rilevazioni etnografiche realizzate a Teggiano, include una serie di racconti e favole, canti d'amore, indovinelli, ninne nanne, proverbi e scioglilingua, storie di santi, racconti di magare e streghe, ma soprattutto spiccano alcune pregevoli performance musicali eseguite da suonatori di organetto e cantori locali. Emerge, dalle interviste e dalle esecuzioni, l'uso centrale della musica e in particolar modo dei canti nella vita comunitaria, come forma espressiva elaborata e linguaggio non ordinario utile ad esprimere concetti e messaggi "indicibili". Tra i testi, eseguiti nel canto o semplicemente recitati, si possono individuare alcuni utilizzati nelle serenate con la funzione di chiedere il permesso di cantare, di esprimere messaggi e intenti amorosi, o di saluto e commiato per i genitori e i parenti della promessa sposa. Un elaborato repertorio che mostra le raffinate e straordinarie qualità estetiche e compositive della cultura orale del luogo.
00 Rosa Di Lillo, Teggiano 1981-82 (01-02)
In questa prima parte delle rilevazioni effettuate da Rosa Di Lillo a Teggiano sono documentati canti monodici e a distesa con testi ironici e di argomento amoroso, versi recitati, favole, filastrocche, preghiere, ricette culinarie, storie di briganti (tra cui una lunga monografia sul brigante Salvatore di Sassano), storie di vita, aneddoti su luoghi e personalità dell'area, canzoni e racconti di guerra, ninne nanne, tarantelle e mazurke. Un vasto corpus di informazioni e dati che fornisce un'ampia ed eterogenea panoramica sulla cultura orale, le tradizioni e la storia del luogo.
00 Rosa Di Lillo, Teggiano 1981-82
L'imponente mole di registrazioni presente in queste raccolte, realizzate da Rosa Di Lillo tra il 1981 e 1982 per un lavoro di tesi per l'Università di Salerno, fornisce un'ampia e significativa documentazione sulla cultura orale di Teggiano (Sa). L'indagine etnografica raccoglie testimoninze dalle voci di anziani ancora legati ad una dimensione orale che ha tramandato di generazione in generazione esperienze e memorie. Le storie, i canti e i cunti, la loro diffusione e il largo uso, le molteplici interpretazioni e versioni, sembrano evidenziare se non proprio una cultura orale primaria, nei termini indicati da Walter Ong, una cultura con forti residui di oralità. Molte delle storie e dei testi, riportati da diversi informatori con piccole o significative variazioni, mostrano un continuo sovrapporsi di saperi e fatti che si sono ripetuti "a voce" nel tempo, per stratificarsi e andare a formare una sorta di memoria collettiva: una fonte risonante di conoscenze e cognizioni che fornisce un forte ancoraggio al passato e al "dominio degli antenati", riprendendo Ong. Le tipologie di documenti spaziano da interviste sulla storia locale a narrazioni di racconti e favole, recitazioni di scioglilingua, preghiere vernacolari, formule magiche e apotropaiche, testi d'amore e di scontro, ninne nanne, filastrocche, barzellette, storie di briganti, storie di magie e streghe, performance musicali, tarantelle e mazurke. Particolare rilevanza numerica hanno i canti d'amore (purtroppo nella maggior parte dei casi semplicemente recitati), le favole e i cunti. Tante anche le testimonianze e i ricordi sulla presenza del brigantaggio nell'area, tra le quali spiccano le vicende sul brigante Salvatore di Sassano. Di rilievo anche le testimonianze sull'utilizzo delle serenate con varianti d'amore, d'ingiuria o anche per vino e salsicce (per puro divertimento, probabilmente collegate al periodo del carnevale). Come spiegano gli informatori, i canti e le serenate non sempre avevano buoni intenti e parole d'amore, potevano anche offendere e servire in tal modo a risolvere rivalità, evitando possibili ricorsi alla violenza fisica. Il canto, con testi d'amore e d'ingiuria, in base a quanto emerge dalle testimonianze, aveva un largo uso; molti testi sono conosciuti e interpretati da più esecutori, elemento che denota un ruolo e una funzione centrali della musica e dei suoni nella vita collettiva. In particolar modo, l'utilizzo del canto e dei testi, sia d'amore che di scontro, per esprimere messaggi "indicibili" ma comprensibili da tutti, utili per comunicare informazioni a coloro che conoscono e utilizzano quella forma espressiva, segnala un impiego della musica nella vita comunitaria come strumento culturale elaborato, superando il linguaggio ordinario. I canti erano accompagnati con l'organetto e tra le registrazioni si trovano anche alcune pregevoli performance di anziani esecutori. Ascoltando queste registrazioni è immediatamente chiaro che siamo di fronte a un mondo altro, a una dimensione culturale e di conoscenze non ancora mutilata o deturpata dalla dilagante e omologante cultura della sovrabbondanza di informazioni e suoni. La spontaneità e intimità degli incontri tra autrice e informatori, sembra rendere ancor più autentico, su un piano squisitamente etnografico, il lavoro d'indagine, offrendo la possibilità di contatto e confronto con la fantasia, le conoscenze e i saperi di una cultura orale ormai lontana nel tempo.
000 Pregiato di Cava de' Tirreni 1981
Breve raccolta di testimonianze sul culto di San Nicola documentate nel 1981 a Pregiato, piccola frazione di Cava de' Tirreni (Sa). Fulcro dei festeggiamenti in onore del protettore è ancora oggi la chiesa parrocchiale intitolata al santo patrono celebrato il lunedì in albis, in ricordo di quando, nel 1944, minacciati dall'eruzione del Vesuvio, i contadini del posto, preoccupati per le sorti delle loro terre, chiesero al parroco di portare in processione la statua del santo per proteggere e benedire la fonte del loro sostentamento. Fu così che la lava si fermò e da allora ogni lunedì in albis la processione si ripete ricordando la grazia ricevuta.
In passato, nei giorni precedenti, veniva organizzata un'asta (traccia 02) in cui gli uomini del paese si contendevano l'onore e il prestigio di portare il santo in spalla. Come riportato dalla testimonianza di un banditore (traccia 01), già negli anni Ottanta i riti in onore di San Nicola a Pregiato erano andati sempre più semplificandosi e oggi non si svolgono più aste, ma a turno i fedeli conducono la statua del santo lungo il percorso processionale che dura dalle due alle tre ore.
000 Pellezzano 1979
Una selezione di brani musicali, canti e interviste, registrata sul campo in presa diretta, documenta i riti che si svolgono a Pellezzano (Sa) in onore di Sant'Anna protettrice delle partorienti e da molti considerata compatrona della città.
Fede e tradizione si fondono durante la festa che ogni anno, la domenica successiva al 26 luglio (giorno di Sant'Anna), richiama nella chiesa parrocchiale di San Clemente migliaia di fedeli provenienti da tutta la provincia. Credenza e devozione muovono migliaia di donne che percorrono a piedi, a mezzogiorno, il lungo tratto in salita che conduce alla chiesa madre, già nota nel 1138, dove si venera una statua della santa a mezzo busto e lo stesso giorno si celebrano quattordici Santi Martiri cristiani (in processione si portavano anche le statue di S. Gioacchino, marito di Sant'Anna, e S. Clemente, patrono di Pellezzano).
Già prima della mezzanotte, cominciavano a giungere i primi pellegrini dai paesi limitrofi, molti dei quali scalzi e moltissimi vestiti dei colori della santa, il verde e il giallo. I pellegrini portavano un tempo grosse ceste di viveri che consumavano durante la notte tra canti, balli tradizionali, sfilate di carri allegorici, giostre e proposte alimentari di ogni genere (tipicamente la milza cotta nell'aceto, la zuppa di soffritto, le melanzane, le lumache e i meloni). Ai primi chiarori dell'alba, la chiesa veniva aperta e i pellegrini avanzavano cantando inni di lode alla santa; molte donne procedevano fino all’altare in ginocchio, altre lo facevano rotoloni per terra, altre ancora strisciando la lingua sul pavimento. Verso le ore undici la statua era rimossa dalla nicchia e collocata sulla portantina per la processione: le donne allora si accalcavano nel tentativo di spolverarla con fazzoletti o lembi di stoffa poi conservati come reliquie. La processione era preceduta dalla sfilata delle verginelle, velate di bianco e scalze, che chiedevano la grazia per sé e per le proprie famiglie. Al passaggio da Casa Genovese, venivano fatti scendere, con corde e carrucole, due angeli che rendevano omaggio alla santa. Fino al rientro in chiesa delle statue non si accendevano nelle case fuochi per cucinare: solo dopo, quando i pellegrini iniziavano il loro viaggio di ritorno, i pellezzanesi ritornavano a casa per preparare la "zuppa di Sant'Anna, una pietanza a base di fiori di zucca, zucchine e patate cotti con l’osso di prosciutto.