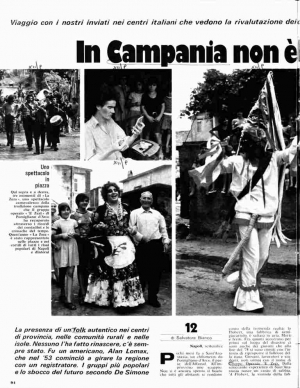Mimmo Ferraro
000 Sant'Eustachio 1978
Canti popolari, filastrocche e cunti eseguiti dalla signora Melania Alfiusito, registrata a Sant’Eustachio, piccola frazione nel salernitano: nell’arco di tre giorni, dal 10 al 13 aprile del 1978, la ricercatrice, della quale purtroppo non si conosce l'identità, raccoglie la testimonianza di un'antica tradizione orale. La sola voce della donna accompagna l’ascoltatore in un viaggio tra canti devozionali, tammurriate, canti d’amore e a’ffigliola, ricostruendo non solo uno spaccato della tradizione orale di Sant’Eustachio, ma anche rispecchiando le influenze e le eredità culturali delle zone limitrofe. Ritroviamo così canti in onore della Madonna di Montevergine e della Madonna dei Campi, versi dedicati a San Francesco o semplici canti d’amore.
000 Salvitelle
Un'eterogenea raccolta di canti, storie, testimonianze, raccolte a Salvitelle, comune della provincia di Salerno, al confine con la Basilicata. La ricercatrice, in un ambiente a lei familiare, ricostruisce, attraverso la testimonianza di un uomo e di una donna, dei quali purtroppo non si conosce l'identità, il ricco patrimonio di cultura orale del paese: tra canti devozionali, cunti, filastrocche e storie di vita si delineano la storia, le tradizioni e le credenze di un'intera comunità. La lunga intervista, raccolta probabilmente poco tempo dopo il terribile terremoto che colpì l'Irpinia il 23 novembre del 1983, ricostruisce, in un racconto intimo e sofferto, i difficili momenti attraversati dalla gente di Salvitelle e descrive le ferite, ancora vive, lasciate nelle vite e tra le strade del paese. Attraverso l'esecuzione di canti e descrizioni minuziose, arricchite di ricordi e storie familiari, gli intervistati presentano l'ingente patrimonio di usanze e culti praticati paese. In particolare, si soffermano sulla devozione verso il santo patrono: la festa in onore di San Sebastiano cade il 20 gennaio, quando si svolgono le liturgie religiose, mentre i riti civili sono stati spostati, per evitare la rigidità del clima, all'ultima domenica di agosto; la statua del santo viene portata in processione per le vie del paese unitamente alla statua di san Giuseppe, precedente protettore, ed i cittadini si contendono all'asta tale privilegio, il cui ricavato viene utilizzato per l'organizzazione dell'anno successivo. In tale occasione si svolgono anche il "torneo di lotta greco-romana" e la tradizionale corsa a piedi nudi "Serra San Giacomo": i partecipanti, rigorosamente nati o residenti a Salvitelle, scendono a piedi nudi tra rovereti e sterpi dalla cima del Monte San Giacomo alla chiesa di San Sebastiano dove baciano per devozione il piede alla statua prima di immergere i propri, inevitabilmente feriti a causa del terreno accidentato, in tinozze di vino risanante. Si parla, inoltre, in un tono intimo e familiare, di ricette, riti ed usanze legati alla magia e alla medicina contadina, tra rimedi erboristici e formule magiche. Un ricco patrimonio di cultura orale, dunque, che si presenta come esito di un'osservazione partecipante, dove la distanza tra ricercatore e testimone si riduce al minimo, in una narrazione corale, probabilmente specchio di una condivisione da parte della studiosa della realtà culturale e dell'esperienza di vita dei suoi interlocutori.
000 Sala Consilina 1980
Interviste realizzate prima e durante i giorni della festa di San Michele Arcangelo, santo patrono di Sala Consilina. I festeggiamenti iniziano la sera del 28 settembre quando si porta in processione una barca con l'Arcangelo, preceduta da ragazzi e suonatori che inneggiano al santo e trasportano lu giardinu ri San Micheli, una sorta di trofeo carico di uva e primizie agricole. Il percorso attraversa il paese e si ferma davanti alle ventidue/ventitre immagini del santo che si incontrano durante il tragitto, per invocare San Michele con formule religiose e canti. La festa ha un carattere decisamente popolare e contadino, nel senso che scarsa rilevanza e partecipazione hanno le cariche religiose, forse per i molteplici riferimenti e rimandi pagani presenti nella manifestazione. La serata termina davanti al santuario dove i fedeli si fermeranno a passare la notte tra preghiere e canti invocativi. La mattina del 29 la statua è riportata in paese dove viene agghindata di ex voto e vessilli; alla processione per le vie cittadine partecipano anche le cariche religiose. Il corteo si ferma davanti ad altri giardini di San Michele,impalcature allestite nella piazza adiacente alla chiesa di Sant’Eustachio, che contengono edera, fiori, ortaggi e grappoli d'uva offerti al santo e ai fedeli in processione. Qui si svolge inoltre il volo dell'Angelo: un bambino dentro una carrucola, legata ad una fune tra due balconi dello spiazzo, vola per tre volte recitando formule e invocazioni per il santo. In passato il rituale comprendeva anche altri momenti tra i quali l'incendio del Vecchio e della Vecchia, due pupattole caricate con fuochi pirotecnici (traccia 06). Le prime interviste presenti nella raccolta contengono le testimonianze di alcune donne che parlano della festa dell'Arcangelo e di altre feste e pellegrinaggi per le Madonne celebrate nell'area (le informatrici non sono di Sala Consilina ma probabilmente di qualche frazione o paese limitrofo). Nelle altre rilevazioni è documentata la festa a Sala, con informazioni sui i rituali, sacri e laici, le usanze e i piatti tipici, le formule e le invocazioni recitate per il santo patrono.
000 Rosa Di Lillo, Teggiano 1981-82 (13-14)
La raccolta aggiunge ulteriori informazioni e dati etnografici all'ampio lavoro d'indagine realizzato a Teggiano nel 1981/82 da Rosa Di Lillo. Nello specifico questa raccolta, oltre a una serie di testi di argomento religioso e d’amore, ninne nanne, cronache sulla storia e le tradizioni locali, informazioni sul culto dei morti, contiene soprattutto una larga parte di documenti che possono inscriversi nel repertorio comico e fantasioso della tradizione orale del luogo. Repertorio espresso attraverso una serie di storielle, favole, barzellette e indovinelli, che mettono in risalto l'aspetto ironico, creativo e ingegnoso della cultura popolare.
000 Rosa Di Lillo, Teggiano 1981-82 (11-12)
Una delle raccolte più ricche sul piano musicale nel quadro generale del lavoro etnografico condotto da Rosa Di Lillo a Teggiano. Le rilevazioni documentano un ampio repertorio di canti d’amore e di sdegno o ingiuria, non solo recitati ma spesso eseguiti. È possibile apprezzare alcune linee melodiche dei canti, realizzate dalle voci di anziani esecutori, che permettono di evidenziare forme estetiche e ritmiche della tradizione musicale locale. Discorso a parte meritano i canti di scontro: i testi lasciano intuire un largo uso del canto come mezzo di comunicazione centrale e linguaggio non ordinario per l'espressione di messaggi moraleggianti, offese e invettive; non sono presentate o riportate dagli informatori occasioni e modalità d'uso ma è molto probabile che fossero utilizzati nei momenti di lavoro agricolo, o nello spazio pubblico del paese, quindi strade e piazze, verosimilmente in generi come la serenata, i canti carnevaleschi, e più in generale in momenti di aggregazione sociale. Ad arricchire la raccolta storie e fatti della vita locale, con alcuni aneddoti ed episodi di magia popolare, ninne nanne, canti religiosi, racconti e favole.
000 Rosa Di Lillo, Teggiano 1981-82 (09-10)
La più ampia tra le raccolte su Teggiano realizzate da Rosa Di Lillo, si caratterizza per una larga presenza di testi e canti di argomento amoroso. Gli informatori elencano una lunga serie di versi d'amore utilizzati nelle serenate, spiegandone le occasione e funzioni d'uso. Emergono, da un'intervista ad un cantore di serenate, informazioni sulle modalità d'esecuzione, le occasioni, i contesti e il senso delle diverse tipologie di serenate (per amore, per vino o per salsicce). Ad arricchire la raccolta cunti e fiabe, strofëlë (filastrocche), canti religiosi, ninne nanne, storie di magia e possessione, eventi e fatti della storia locale; una collezione rilevante di forme ed espressioni della cultura orale del luogo.
000 Rosa Di Lillo, Teggiano 1981-82 (07-08)
La raccolta riunisce una serie di documenti eterogenei, dai quali affiora una quantità ingente di informazioni sulle tradizioni e gli usi della cultura locale. Oltre ai testi d'amore, alle preghiere in vernacolo, agli scioglilingua e alle filastrocche, ai racconti e alle storie di briganti, lunghe interviste su tradizioni natalizie, il carnevale, la Quaresima, le vendemmie e le serenate.